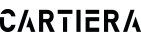Finalmente pubblicata la nuova strategia europea per il tessile
La si aspettava da tempo, perché, come già sottolineato nei più recenti documenti europei, dall’EU Green Deal (2019) al Circular Economy Action Plan (2020) all’EU Industrial Strategy (2021), il settore del tessile è stato identificato come uno dei più critici in termini di impatto ambientale. Lo scorso 30 marzo la Commissione europea ha pubblicato la nuova EU Strategy for Sustainable and Circular Textile, con lo scopo di fornire le prime linee guida per la riconfigurazione dell’intera industria.
Il nuovo documento argomenta, dati alla mano, le ragioni per le quali tale settore è considerato di prioritaria importanza. L’ecosistema del tessile coinvolge in Europa 160.000 imprese, 1,5 milioni di lavoratori e genera un giro di 162 miliardi di euro annui (2019). Il trend produttivo ha registrato un continuo aumento negli ultimi anni, in cui parallelamente alla crescita della produzione di tessuto (quasi raddoppiata nel periodo 2000-2015) è aumentato il numero di abiti “scartati”: all’interno dell’Unione Europea vengono destinati a smaltimento 5,8 milioni di tonnellate di tessuto ogni anno, circa 11 kg per ogni abitante.
Il fenomeno del fast fashion ha incentivato e continua a incentivare i consumatori ad acquistare abiti di bassa qualità e a minor prezzo, consentendo loro di essere sempre allineati agli ultimi trend di stile ma rinunciando a tutte le caratteristiche di sostenibilità del prodotto: gli abiti hanno un basso tasso di utilizzo (sono scartati dopo pochi lavaggi per la scarsa resistenza o perché passati di moda), di riuso, di riparazione e di riciclo. Un simile trend ha comportato un drastico aumento delle produzioni, mettendo a rischio la fornitura di materie prime ed esasperando la generazione di rifiuti da smaltire.
Risulta quindi urgente impostare un nuovo modello di produzione, consumo, e smaltimento che guardi alla circolarità come principio da seguire. Ma quali sono le azioni da mettere in campo per promuovere un cambiamento strutturale ed inclusivo?
All’interno del documento, la Commissione ha identificato alcuni punti chiave su cui intervenire.
Ecodesign
Il design ha un ruolo fondamentale: è da esso che dipende la durabilità, la capacità di riutilizzo, di riparazione o di riciclo di un prodotto. Identificandolo come una delle attività chiave, la Commissione apre a nuove pratiche di Eco-design, in cui l’impronta ambientale di un capo diventa prioritaria rispetto alla capacità di rispondere a un determinato stile o trend.
Il primo scopo di una progettazione eco-compatibile è quello di “allungare” il ciclo di vita dei prodotti. Rendere i capi più durevoli comporterebbe infatti un doppio vantaggio: da una parte, diminuirebbe il numero di nuovi articoli realizzati ogni anno e, di conseguenza, meno intensivo l’utilizzo di materie prime vergini; da un’altra, eviterebbe che abiti con pochi anni di vita – non riutilizzabili per la bassa qualità – vengano destinati a smaltimento indifferenziato.
Strumenti come l’EU Ecolabel Criteria for Textile Products , l’EU GPP Criteria for Textile Products and services o l’Ecodesign for Sustainable Products Regulation (pubblicato nel 2022) definiscono le caratteristiche che contraddistinguono questo tipo di manufatti, a partire dalla composizione chimica. Circa quest’ultima, anch’essa stabilita in fase di design, la Commissione sottolinea la necessità di sostituire le sostanze pericolose o altamente impattanti – in particolare le microplastiche – con soluzioni meno inquinanti. Il documento Commission Initiative to adress the unintentional release of microplastics in the environment, previsto per la fine del 2022, avrà lo scopo di supportare questo cambio di rotta.
Se il passaggio a un design eco-compatibile ci permetterà di intervenire a monte dei cicli produttivi, risulta altrettanto importante trovare nuove soluzioni per le ultime fasi della catena, ovvero la gestione e la riqualifica degli scarti e dei rifiuti.
Stop alla distruzione dell’invenduto
L’Ecodesign for Sustainable Products Regulation porrà alle imprese il divieto di distruggere i capi resi o invenduti, che potranno invece essere destinati a riciclo o al mercato second hand. Le aziende saranno vincolate a comunicare in modo trasparente il numero di abiti che, una volta arrivati a fine del loro ciclo di vita, verranno mandati a smaltimento, e quelli che invece saranno trasformati tramite pratiche virtuose.
EPR – Extended Producer Responsibility
Ad oggi, in Europa, solamente il 38% degli abiti usati viene destinato ad attività di upcycling o riciclo, mentre il restante 62% viene scartato in modo indifferenziato. Come diminuire un simile trend?
L’EPR – Extended Producer Responsibility – è uno strumento che impone al produttore la responsabilità su tutto il ciclo di vita del prodotto. Se molti governi hanno già imposto tale condizione come obbligatoria per le proprie imprese, la Commissione, tramite il Waste framework directive, si propone di estendere tale norma a tutti i paesi membri entro il 2023. Sarà inoltre vietato esportare i capi da smaltire in paesi non OECD, salvo quelli che hanno dimostrato di saper gestire in modo sostenibile simili carichi.
Le novità fino ad ora analizzate intervengono direttamente sulla catena produttiva, ponendo nuove regole per il design e per la gestione degli scarti. Gli ultimi due punti interessano invece il rapporto produttore-consumatore, in cui la trasparenza viene posta come condizione necessaria per una transizione efficace e misurabile.
Passaporto digitale di prodotto e Green Claims Initiative
L’Ecodesign for Sustainable Products Regulation introduce l’obbligo di Passaporto Digitale per tutti i prodotti tessili, in cui dovranno essere riportate le informazioni inerenti all’impatto ambientale e alla circolarità del manufatto. Grazie a tale strumento, i consumatori potranno essere più consapevoli – al momento dell’acquisto – dell’impronta ecologica dell’articolo scelto.
Sempre nell’ottica di fornire informazioni corrette circa la durabilità, le possibilità di riparazione, l’impatto ambientale della produzione di un articolo, sarà pubblicato il Green Claims Initiative entro la fine del 2022, un documento finalizzato a combattere le pratiche di green washing: sarà infatti vietato alle imprese utilizzare claims di sostenibilità (green, ecofriendly) quando non comprovati da enti terzi.
Il nuovo modello
Per realizzare le azioni previste e favorire la collaborazione tra i vari stakeholders, la Commissione attiverà dei nuovi strumenti digitali definiti Transition Pathways.
In particolare, il Transition Pathway for the Textile Ecosystem, previsto per il secondo quadrimestre del 2022, offrirà uno spazio virtuale per condividere best practices e innovazioni tecnologiche, oltre a fornire un utile strumento alla Commissione per indirizzare i futuri investimenti. In collaborazione con imprese e attori del settore, uno dei principali obiettivi sarà quello di generare un nuovo trend opposto a quello del fast fashion, in cui il prodotto si trasforma in servizio e le capacità di riparazione, riuso e riciclo ne diventano parte intrinseca.
Iniziative come New European Bauhaus, #ReFashionNow, European Partnership Process4Planet o Hubs4Circularity, testimoniano i passi già mossi in questa direzione.
In ultimo, un breve focus viene dedicato alle condizioni sociali e alle competenze dei lavoratori coinvolti. Da una parte, sarà fondamentale investire nella trasmissione delle skills necessarie alla nuova idea di produzione, come l’eco-design o l’upcycling. Dall’altra, dovranno essere messe in atto misure atte a prevenire lo sfruttamento delle persone, con particolare attenzione al lavoro minorile.
Le imprese sociali attive nel campo del riutilizzo avranno un compito fondamentale in questo percorso, in quanto enti capaci di coadiuvare lavoro dignitoso e sostenibilità ambientale. Il Laboratorio Cartiera, impegnato da anni nella trasformazione di materiali dismessi e nell’empowerment di persone fragili, rappresenta in quest’ottica un modello da seguire e replicare, in cui il prodotto diventa uno strumento in grado di generare impatto.
Un documento che segna solo l’inizio di un lungo percorso, che coinvolgerà imprese, professionisti e consumatori, e a cui tutti noi siamo chiamati a partecipare.